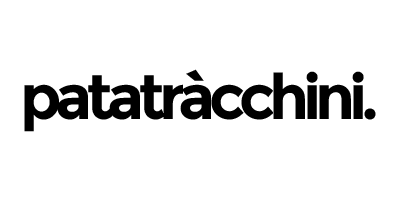09 Dec cechov.
Aveva appena visto uno spettacolo di Cechov, Ivanov per la precisione: era stanco, ma sereno. Erano vent’anni che non si sentiva così sereno; tutta questa sua serenità, peraltro, si basava sull’aver accettato il fatto che non si potesse essere sempre sereni. Non era questa assiomatica questione, però, l’unica sintetica ragione della sua profonda rilassatezza; contribuivano alla causa il fatto che si sentisse completamente innamorato, il fatto di aver cambiato le fondamenta stesse della sua precedente esistenza, il fatto di avere smesso di temere il nuovo e, con esso, il futuro. Tutto questo caotico eppure lampante mucchio di cose gli consentiva di sentirsi felice, triste, arrabbiato, nauseato, anche normale certe volte, ma sempre e comunque sereno, paziente, sdraiato; come se dentro il suo originario sé verticale fosse riuscito a costruirsi anche un sé orizzontale, e ora tutta la faccenda risultasse logicamente più solida. Con questi precari pensieri se ne tornava verso casa mischiando i fatti suoi a quelli del più famoso Nikolaj Alekseevič. Una sera come tante, gli sembrava, resa un po’ più russa se non dal dramma, certamente da un imponente sciopero dei mezzi pubblici. Saltellava, dunque, o meglio rimbalzava tra il marciapiede e le fermate del tram, un po’ augurandosi di vederlo arrivare, un po’ no. Nel tessere questa invisibile trama urbana notturna, leggermente sovietica, aveva superato e si era fatto superare, per almeno tre volte, da una ragazzo altissimo. Il gigante aveva tutta l’aria di essere un enorme clochard, addosso abiti sporchissimi e in testa un colbacco scuro. Al posto del prevedibile sacchetto della spesa, si trascinava però dietro un ciclopico sacco di plastica trasparente contente diverse coperte piegate con cura. Non era possibile non notarlo, ma lo aveva trattato con un numero equo di sguardi, interessato ma non toccato, distratto dalla sua serenità di quel momento, da quel colpo di pistola, da lei che magari non si era ancora addormentata e adesso lui arrivava a casa in tempo per parlarle (ancora una volta) di quel colpo di pistola. Pensare a lei lo aveva fatto accelerare senza accorgersi. Aveva superato rapidamente l’omone e buttava lo sguardo verso i binari: adesso sperava nel tram, non guardava più la strada, non sentiva più la sera, non pensava che niente fosse ridicolo o offensivo, non era più perso nella notte. Di colpo aveva sentito come una sfera metallica arrestarlo sul petto. Un fuoco rotondo e lucido, invisibile. Si era fermato perché non avrebbe potuto fare altrimenti, si era voltato di scatto per guardare, come se la sfera lo avesse aggirato e gli fosse scomparsa alle spalle e a lui fosse venuto un incontrollabile desiderio di seguirla. Dietro di lui, il gigante, quel mastodontico vagabondo, lo stava raggiungendo, pochi passi e nell’incrociarlo, gli aveva posato la pesante mano sul braccio sinistro e l’aveva lasciata lì qualche secondo; poi lo aveva superato continuando a spostarsi sulle spalle il bagaglio ingombrante e però camminando come se i piedi gli stessero fischiettando. Era rimasto così, impietrito al centro del marciapiede a domandarsi cosa fosse successo, perché quel tocco sconosciuto non lo avesse impaurito, non l’avesse destabilizzato, non lo avesse preoccupato; a domandarsi perché, anzi, quel tocco non lo avesse neanche sorpreso, l’arto diventato completamente caldo dopo il contatto, gli occhi lentamente lanciati dal braccio all’uomo, dall’uomo sempre più lontano al braccio sempre più caldo, calde anche le spalle, calde la schiena, la pancia, le gambe, la faccia. Era tornato a casa a piedi con addosso quella sua serenità, quei passi leggeri che si usano quando non si capisce dove si stia andando. Chiusa la porta, un qui e un altrove: nel cuore, quasi evaporato, una grandissima voglia di fare silenzio.
(Illustrazione di Paola Codutti)