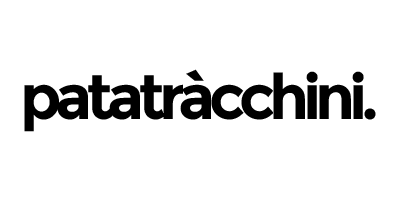11 Sep hotel supramonte.
Grazie a te ho una barca da scrivere, un treno da perdere.
(Hotel Supramonte – Fabrizio De André, Massimo Bubola)
Da quanto siamo in questa stanza? Non lo so.
All’inizio ho provato a contare i giorni su un pezzo di carta che avevo trovato in un cassetto; poi mi sono fidato di me stesso: ho tenuto il conto a mente, promettendomi ogni giorno di rimettermi in pari sul foglio, ma io non faccio mai quello che prometto, considera questo.
Da quanto siamo in questa stanza quindi, non lo saprei dire. Non posso sperare di intuire il tempo dalle stagioni che passano, ché un certo giorno, d’improvviso, è arrivato il freddo e non se n’è più andato. In silenzio mi è scesa la neve in gola, si è poggiata prima sulla pianta dei piedi, poi si è accumulata fino alle ginocchia, ha riempito le cosce; ha raggiunto la pancia, le spalle: sono sommerso di neve, dal di dentro. Se ci fosse il sole, tutta questa neve farebbe in un attimo a tornare acqua, ma il sole non c’è, considera questo. Sulle grandi finestre hanno poggiato pannelli spessi di legno leggero. Lo spessore vuoto copre la luce, unisce il giorno e la notte in un eterno annoiato pomeriggio.
Perché ci hanno fatto questo? Passeggiavamo, io e te, quel giorno. La luce bianchissima spruzzava i rami più alti degli alberi, l’odore di bosco incendiava le narici, i rumori erano ridotti a un concerto svogliato di uccelli liberi e foglie mosse da un vento leggero. Non dicevamo nulla, non ci tenevano neanche per mano; ci sapevamo dai respiri, lenti di cotone: vibrazioni eloquenti per due come noi. Ogni tanto però ci guardavamo le bocche lucide, le gambe sottili, le ginocchia, i capelli spettinati, le cicatrici, gli occhi stretti a fessura per tenerci dentro un po’ di sole; solo ogni tanto però, considera questo. Ti ero abbastanza vicino per sentire distinto l’odore d’erba che avevano i tuoi capelli.
Ora sanno di polvere e sporco e lo so perché anche adesso provo a tornarti vicino come quel giorno, provo a avvicinare la mia testa alla tua, e ci spero tutte le volte, che ora chiudo gli occhi e ce la facciamo a uscire da questa stanza. Usciamo e torniamo a passeggiare nel bosco, io e te; torniamo a casa a fare l’amore lenti, senza che niente di niente ci possa disturbare.
Io torno a scriverti lettere d’amore seduto nello studio – lettere che c’hanno mozziconi di sigarette al posto delle virgole e bicchieri vuoti al posto dei punti. Tu torni a salutarmi dal giardino con la mano tesa mentre con l’altra t’asciughi la fronte – la tua bellissima fronte, amore – e riprendi a scavare la terra, riprendi a cercarci dentro la voglia di curarti di me per un altro giorno.
Ci hanno presi in un secondo: hanno preso prima me. Da subito non mi sono preso pena, lo sai come sono fatto. Sono stato nascosto in me stesso, da solo, per tutta la vita; i posti mi sono sempre sembrati fatti solo per essere lasciati: io sono quello che va via, e anche quella volta, considera questo, mi era sembrato un sollievo che fosse qualcun altro a portarmi via al posto mio, a togliermi persino il fardello di doverlo fare da solo e di dover dare una spiegazione.
Poi dopo hanno preso te, amore, ma tu sei diversa: tu hai urlato, hai resistito, hai preteso un motivo. Nessun motivo. Perché ci hanno fatto questo? Perché non potevano fare altrimenti, amore, l’ho capito adesso; hanno fatto quello che hanno potuto, come fanno tutti: considera questo.
Non mi ricordo il tragitto: non so come siamo arrivati qui; seduto in macchina cercavo solo di calmarti, di tenerti ferma, di garantirti che non poteva essere una cosa poi così pericolosa, di rassicurarti sul fatto che niente dura per sempre, figurati questo.
Mi ricordo solo in modo confuso il momento in cui hanno chiuso la porta della stanza. Indifesa in un angolo, hai chiesto di uscire, per favore di uscire; io ho sentito il clic della porta e avrei voluto dirtelo, amore, la verità è che da qua non si esce più; ma ti ho ingannata di speranze, di promesse, ti ho raccontato le mie storie del futuro, le mie solite storie, quelle piene di baci rubati, di sconosciuti incredibili, di notti senza la fine, di fondi di caffè, di treni persi mentre corriamo senza fiato, ridendo di noi stessi e della nostra incapacità. Con quelle assurde favole ho cercato di sottrarre alla disperazione la tua attenzione. Guarda me, amore, guarda me.
Ci portano tre pasti miseri al giorno. Ci fanno allontanare dalla porta – i primi giorni lo facevano gridando, adesso ce lo chiedono pacati quelle poche volte che non lo facciamo in anticipo – poi uno entra, è sempre solo: ne vedo sempre solo uno, considera questo, e poggia il vassoio con i piatti di ceramica sul pavimento. Sono istanti in cui, a turno, ci illudiamo di vedere nello spazio regolare dell’uscio socchiuso un ricordo di libertà, un ricordo di scelta, di pasta al pesto, di caldo. Momenti in cui a turno chiediamo d’essere lasciati andare; riceviamo secchi no, riceviamo spalle alzate, sguardi di pena come se lo sapesse questo che ci guarda, che una volta fuori non sapremmo neanche più dove andare. La porta si richiude, abbassiamo la testa, rinunciamo, ci lasciamo sfuggire dalle labbra qualche altro mai più.
Quando qualcuno entra nella stanza, io non ti guardo mai, io guardo lui: quel volto sempre coperto da un passamontagna scuro, sconosciuto e inconoscibile che ormai ha qualcosa di familiare, e lo guardo per provare a capire cosa voglia, considera questo.
Ci consentono di guardare la televisione: funziona un solo canale. Certe volte litighiamo per decidere cosa guardare e io provo a farti capire che non è possibile litigare per quale canale guardare quando si ha un solo canale; allora tu sorridi: dentro questo inferno in cui ci hanno messo, amore, tu riesci ancora a sorridermi. Non succede spesso, il più delle volte te ne stai sdraiata a fissare la parete e a piangere, però quando succede che sorridi, io mi sento di nuovo vivo, mi sento che riusciremo a uscirne: si stancheranno di tenerci qua, ci diranno perché, perché proprio a noi, perché questo.
Da quanto tempo siamo in questa stanza? Ho come la sensazione che oggi sia il mio compleanno e penso che come regalo desidererei di chiederti di sorridermi ancora, di tenermi vivo un altro po’, ma non ti dico niente, non ti tocco, perché per sopravvivere in questo pugno di metri quadri bisogna che ognuno faccia il suo, e non sono certo io quello che può farsi vedere debole, considera questo. Devi pensare che sono a posto, amore, devi pensare che lo accetto, che è normale, che non farò niente di pericoloso per portarti via da qui, devi darmi la colpa, devi odiarmi perché odiarmi è quello che tiene viva te.
Sì, deve essere il mio compleanno. Mi sono addormentato dopo pranzo e ho sognato quel giorno che t’ho vista la prima volta e ho pensato che fossi la più stronza del pianeta e sono stato tanto felice di rivederti per come ero capace di vederti allora, ma non è tutto; io penso che deve essere veramente il mio compleanno perché quando ho riaperto gli occhi e sono tornato dal sogno, ho trovato la porta della stanza completamente aperta, considera questo.
Sono uscito dalla stanza, amore, ce l’ho fatta. Nel corridoio buio solo una luce debole proviene dall’ultima porta che è un poco aperta. Ci arrivo davanti, superando un bagno piccolo di mattonelle azzurre. Ci arrivo davanti a questa stanzetta illuminata male, e ci guardo dentro, la televisione accesa su un telegiornale regionale, e tu che prepari la cena sulla cucina economica, tu che versi la minestra in due piatti di ceramica poggiati su un vassoio e mentre l’aria fredda della stanza corrompe il calore della nostra cena, tu che ti infili il passamontagna.
Corro all’indietro sui miei stessi passi, veloce torno nella nostra stanza sicuro di starmi sbagliando, sicuro che la fame o la sete mi abbiano giocato uno scherzo di terrore, ma nella stanza – che mi azzarderei a chiamare nostra, considera questo – tu non ci sei. Ho paura. Vorrei tornare indietro, prenderti per le spalle e pretendere che mi spieghi, ma ho la forza solo di arrivare all’altezza del bagno, di accendere la luce e andare verso allo specchio per cercarmi il viso.
L’immagine che mi torna indietro è una testa sconosciuta coperta da un passamontagna liso: è in quell’istante che ti sento urlare.
Ho dimenticato la porta della stanza aperta, non dovevo, cazzo. Perché noi sappiamo quanto sia pericoloso. Perché noi – solo noi – sappiamo quanto ci sia in gioco.
Esco dal bagno, ti chiedo scusa, vado verso la nostra stanza e chiudo la porta.
(Illustrazione di Anna Parini)